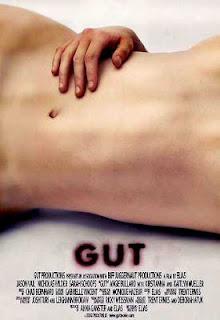Bianco di Roberto di Vito - Genere: drammatico - Italia, 2011
Un uomo si sveglia, senza sapere come, in una stanza. Legato e imbavagliato, l'immobilità è l'unico stato concessogli: non resta quindi che vagare con la mente, alla ricerca di ricordi passati o forse mai vissuti.
Inedito film italiano indipendente, Bianco si muove sul confine fra thriller e drammaticità, riuscendo comunque a ritagliarsi un deciso spazio di manovra nell'intervallo fra due generi rispetto ai quali risulta decisamente eccentrico. Per impostazione, struttura drammatica e realizzazione tecnica, il film di di Vito si prospetta come un prodotto di nicchia e decisamente sopra le righe e a volte sembra voler sfondare i confini stessi del cinema per travalicare nelle videoarti installative (cosa ovviamente possibile, come l'Elephant di van Sant è riuscito egregiamente a dimostrare).
Narrativamente parlando il film è molto povero: la storia si riduce a un rapimento (peraltro, come si vedrà, non riuscito). E' questo, fra parentesi, l'aspetto più debole di tutto il lavoro del regista, perfettamente accettabile invece per altri aspetti ed elementi. Forse troppo concentrato su un'innovazione comunque ben presente, di Vito tratteggia distrattamente dei personaggi che faticano a stare in piedi. Il che, in realtà, non sarebbe neanche un male: quello che mi sarei aspettato è una scelta più radicale, un completo abbandono della narratività per concentrarsi sull'indagine linguistica; sarebbe stata una scelta rischiosa, ma sicuramente più gradevole del limbo di inconsistenza drammatica in cui il regista sceglie di confinare i suoi personaggi, troppo spesso caricaturali e poco convincenti.
Liquidata la parte contenutistica con questi caveat, possiamo passare alla disamina della struttura sintattica della pellicola, certamente più interessante. Un primo pregio che ci permettiamo di segnalare è la presenza di alcune interessanti reminiscenze dal cinema classico d'avanguardia; in particolare mi sembra di aver scorto più volte un ricordo (anche troppo insistente, ma comunque piacevole) della celebre sovrimpressione di Jean Vigo. Se a ciò aggiungiamo alcuni frammenti di montaggio che rincorrono l'effetto Kuleshov, otteniamo un piacevole repertorio di un cinema che molto spesso viene disconosciuto in vista di un maggiore coinvolgimento del pubblico.
Inoltre, gli eventi visivi si muovono agevolmente su diversi piani temporali, lungo i quali siamo trasportati dal peregrinare della mente del protagonista, confinato fra i suoi legacci ma molto attivo nelle libere associazioni della sua psiche. Con nessi di montaggio vicini a quelli del Surrealismo, siamo condotti nei meandri di una mente spaventata e spaventosa, che non trova pace e produce mostri a partire da esperienze vissute o percepite come tali. Questo genera una piacevole sensazione di disorientamento nello spettatore, a cui è lasciato l'ardo compito di ricostruire con dei nessi di significato i tasselli mancanti della vicenda, già molto minimalista: ci viene detto molto poco di una storia già ridotta all'osso.
Da un punto di vista della composizione, come da titolo, la matrice dominante è il bianco, presentato in purezza o in continua opposizione con il nero (gli esempi sarebbero molteplici, tanto che la situazione diventa a tratti decisamente troppo ripetitiva). A dare nerbo a questa struttura a tratti particolarmente fragile è un comparto sonoro (concepito dallo stesso regista) nel complesso molto buono, anche se a volte finisce col ripiegarsi su sé stesso, divenendo semplice sottofondo e non intelligente contrappunto (cosa che invece molto spesso è, soprattutto nelle sequenze più "astratte").
Nel complesso un film denso di spunti interessanti, ma ancora decisamente troppo embrionale dal punto di vista dell'indagine e provvisto di una patina di dilettantismo ancora troppo ingombrante.
VOTO: 6/10