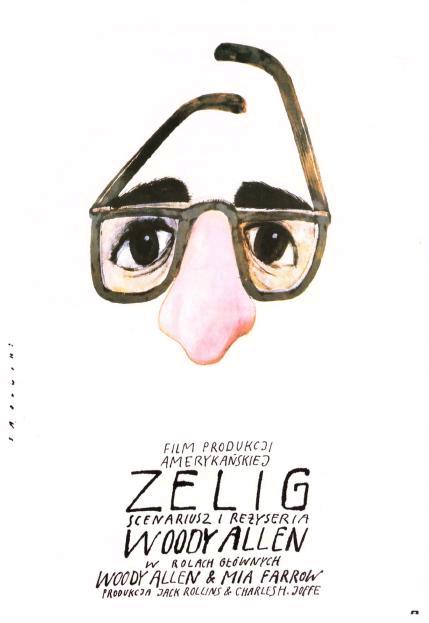Dillinger è morto di Marco Ferreri - Genere: drammatico - Italia, 1969
Adriano Aprà lo ha definito efficacemente il film della mia generazione ed in effetti il Dillinger di Marco Ferreri è senza dubbio una pietra miliare del cinema italiano e non solo. Accolto con entusiasmo dai Cahier e sistematicamente ostracizzato dalla grande distribuzione/trasmissione (rarissime volte è stato proposto in televisione) il lavoro di Ferreri è l'epitome di un nuovo modo di fare cinema, che sovverte nelle sue strutture fondamentali tutta la produzione precedente. In questo profondo rinnovamento delle strutture narrative e stilistiche della cinematografia pre-esistente l'opera di Ferreri viene spesso accostata, anche per alcune vicinanze di pensiero, a quella di Pasolini, forse non completamente a torto.
Dillinger è un film che sembrerebbe essere frutto del caso, come se la macchina da presa del regista si fosse trovata per errore a seguire il peregrinare notturno di un anonimo ingegnere industriale splendidamente interpretato da Michel Piccoli. Così la lunga attenzione che viene riservata alla preparazione della cena, oltre a prefigurare un interesse per il cibo che si connette puntualmente alla tematica della morte e dell'eros (cosa che sarà quantomai evidente ne La grande abbuffata), è rappresentata con una tale attenzione al dettaglio non funzionale che finisce con il risultare volutamente noiosa. Dopotutto, a chi interessa vedere la vita casalinga di una persona come le altre? Basta quest'idea di base a far tremare dalle fondamenta quel cinema dell'eroismo e dello spettacolo su cui Hollywood aveva costruito la sua retorica.
Così Dillinger è morto è un film che fa della manchevolezza narrativa il proprio cavallo di battaglia, tanto che la cosiddetta trama potrebbe essere riassunta in uno spazio minimo senza alcuna perdita dal punto di vista dell'intelleggibilità dell'immagine. Anche il linguaggio utilizzato è semplice, come se il regista volesse creare un'uniformità fra il suo film e quei video amatoriali che il protagonista guarda seduto in poltrona, mentre conclude la sua vera ricetta, che non consiste nella preparazione della cena ma nel "restauro" di una vecchia pistola, trovata avvolta in una pagina di giornale che recava notizia della morte proprio di John Dillinger (da qui il senso del titolo).
E' proprio nel rapporto con le immagini proiettate (e quindi, da un punto di vista meta-artistico, con il cinema), che il protagonista perde sé stesso, rendendosi conto di quale sia la sua condizione e decidendo di perdersi per sempre in quel mare di rappresentazioni illusorie. Per cercare di sfuggire alla vacuità routinaria della sua esistenza (da una nausea di sapore sartriano) alfine, in un ultimo quanto amaro slancio vitalistico, ucciderà la moglie, vista come concrezione materiale di quell'opprimente condizione. Ma dopo che il Nostro, imbarcatosi su una nave come cuoco, vede il cielo tingersi di rosso, lo svelamento della finzionalità dell'immagine rende lo spettatore consapevole che non c'è scampo all'umana condizione.
Dillinger è quindi un capolavoro di drammaticità, che sperimenta nuovi stilemi del linguaggio cinematografico entro una cornice narrativa quantomai debole, tratteggiando un tipo umano dai toni quasi sveviani, ripreso seppure in forma fortemente mutata, da altri personaggi coevi o successivi. Che cos'è il Fantozzi del 1975, se non una versione amaramente comica e forse più disillusa dell'individuo disegnato da Ferreri?
VOTO: 10/10