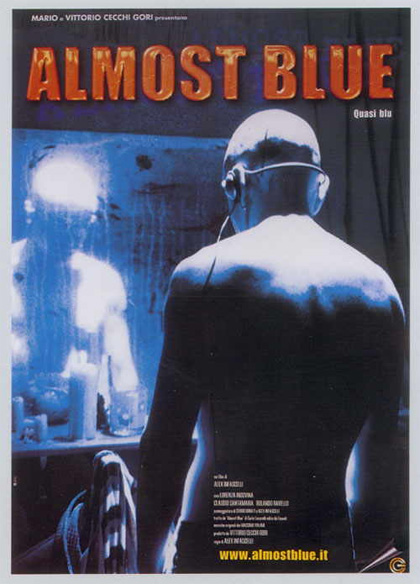Benny's Video di Michael Haneke - Genere: drammatico - Austria, Svizzera, 1992
Un film glaciale, che si apre e si chiude con un inserto in presa diretta girato con una camera a mano (?) in modo amatoriale e impreciso. Tutto è sospeso e contenuto entro questi due momenti, che diventano la chiave di lettura e di interpretazione dell'intera - bellissima - pellicola di Haneke, forse più celebre per l'ugualmente ben fatto Funny games. Con uno spirito indagatore, il giovane Benny, filma l'uccisione di un maiale e la sua agonia dopo aver ricevuto il colpo: il suo sguardo si fa portatore di un'indagine morbosa, tradotta formalmente con l'osservazione attenta del volto dell'animale contorto negli ultimi spasimi.
L'immagine, piantatasi solidamente nel suo immaginario, inaugura una nuova consapevolezza nel protagonista che, moderno flaneur senza interesse ne consapevolezza, vive guardando le immagini sullo schermo. La sua intera esistenza è in effetti mediata e anzi sostituita dall'artificialità di ciò che viene mostrato dalla televisione, dalle cassette della videoteca o da lui stesso. Anche il panorama al di fuori della sua finestra non esiste in quanto tale, ma solo attraverso la mediazione di un apparecchio di registrazione in diretta, che trasmette su uno schermo le immagini riprese in piano-sequenza del mondo esterno, che così facendo si qualifica come entità completamente separata e inattingibile.
Tutto ciò che di significante avviene all'interno della pellicola ha in effetti una natura fortemente mediata, tanto da farci dubitare che ne esista un corrispettivo reale. La stessa uccisione della ragazza, annomima copratogonista di questa vicenda a tratti quasi onirica, viene mostrata in fuori campo proprio su quella televisione che costituisce l'unico elemento di conginunzione fra Benny e il mondo esterno. In questo drammatico disegno esistenziale in cui (a differenza di molti altri commentatori) non vedo una vena di critica sociale alla condizione della gioventù contemporanea, lo spettatore si trova costantemente sospeso fra lo sviluppo di una diegesi particolarmente debole e la rottura di ogni impressione di continuità grazie al costante intervento di frammenti di grana diversa, che costringono chi guarda a ritrovarsi nella stessa condizione gnoseologica del protagonista.
Nel complesso un film violento, interessante e formalmente molto ben fatto che meriterebbe di ricevere una maggiore attenzione di pubblico e di critica (almeno, di una certa parte). E' senza dubbio possibile leggere fra le righe un accenno di critica all'alienazione dell'adolescenza assorbita dal flusso anestetizzante delle immagini, ma credo che eleggere questo paradigma di lettura a chiave interpretativa generale dell'intera opera ne riduca fortemente le possibilità e ne faccia purtroppo dimenticare le felici trovate formali (fra cui, vale almeno la pena di ricordare in extremis il ricorso al riavvolgimento dell'immagine registrate che - si ricorderà - trova la sua massima espressione proprio in Funny Games).
VOTO: 8/10