
Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman - Genere: drammatico - USA, 1975
La tematica della malattia mentale è al centro di diversi lavori cinematografici che di solito la affrontano tracciandone una mitografia negativa, come avviene nel caso di molti thriller (la trilogia su Hannibal Lecter ha fatto scuola da questo punto di vista e i serial televisivi ne hanno tratto grande beneficio). Meritevolissimo quindi il film di Milos Forman, uno dei pochi ad aver vinto tutti e cinque gli Oscar principali, per la modalità narrativa che mette al centro della vicenda la vita all'interno di un istituto di igiene mentale "vecchio stile", con elettroshock e quant'altro.
Il film si colloca nella stagione a mio avviso più felice di tutto il cinema statunitense, in quella Nuova Hollywood che cercava con forza di scrollarsi di dosso l'eredità ingombrante del suo ormai stantio classicismo e voleva svecchiarsi attraverso gli insegnamenti dei maestri europei, primi fra tutti gli autori della nouvelle vague francese. Qualcuno volò sul nido del cuculo è una sorta di operazione sincretica fra le due tradizioni: non rinuncia a un impianto narrativo molto solido che riesce a venir condotto con lucidità e intelligenza per due ore, ma neppure si trincera dietro stanchi e prevedibili stereotipi come il lieto fine a tutti i costi.
Il cast nel suo complesso è meritevolissimo; certamente Nicholson qui è al suo meglio (qui e in Batman, va da sé), ma tutti gli attori riescono perfettamente a calarsi nella propria parte pur senza risultare eccessivi e fuori luogo. La recitazione calcata e mimicamente estrema di Nicholson trova qui la sua forma ideale, non imbrigliata da alcuna regola di comportamento o di gestione: il folle non ha leggi e quindi la magmatica pantomima di McMurphy può liberarsi in tutta la sua eversività.
Il comparto narrativo come si diceva è solido e molto americano, ma non per questo risulta spiacevole o prevedibile, anzi. Il crudo realismo mutuato dalla materia diegetica si sposa perfettamente con una modalità di gestione del ritmo narrativo che rifugge dalla stereotipia e dal coronamento favolistico della circostanze. Ogni qualvolta lo spettatore medio si aspetterebbe un'evoluzione in negativo il film ci fa cadere più in basso nella nera oscurità dell'ospedale, fino al tragico epilogo. Non c'è lieto fine e l'impostazione classica del racconto hollywoodiano viene completamente meno (è vero che alla fine "Grande Capo" riesce a fuggire. ma a che prezzo?).
Il grande merito di film come questo è di riuscire ad essere belli al di sopra della soggettività, di riuscire ad ambire ad una piacevolezza visiva che si svincola dai giudizi personali e che pretende da chiunque un consenso nell'affermare la bellezza del visibile. Davanti a lavori come questi la stessa differenziazione fra cinema narrativo e cinema sperimentale/critico viene completamente meno e rimane solo la settima arte nella sua più pura essenzialità.
VOTO: 10/10











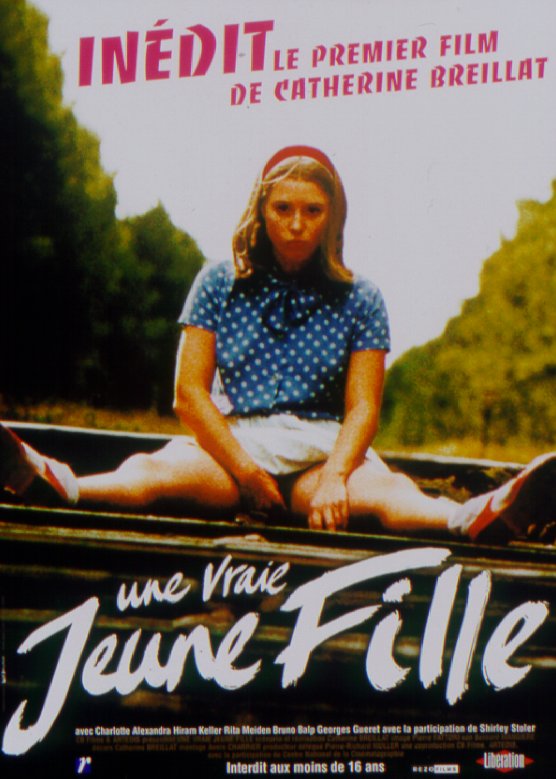


.jpg)










