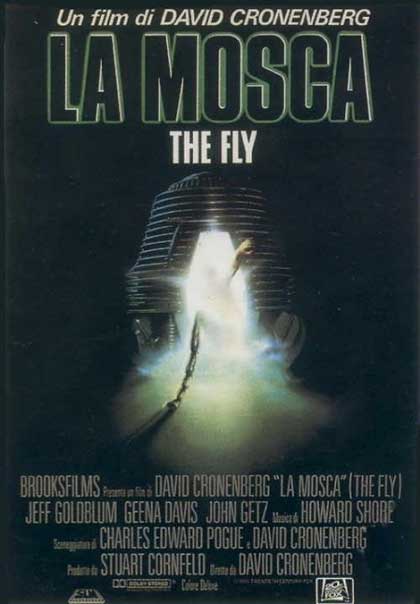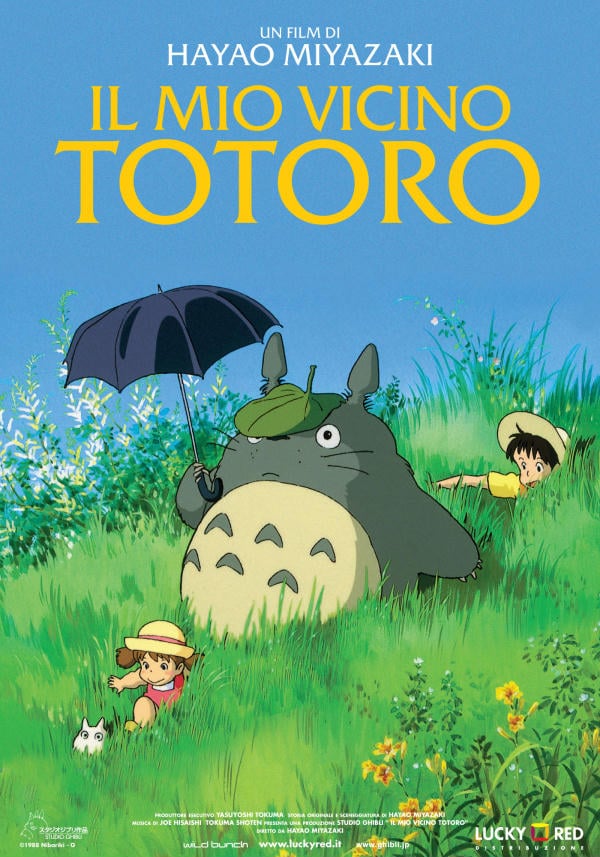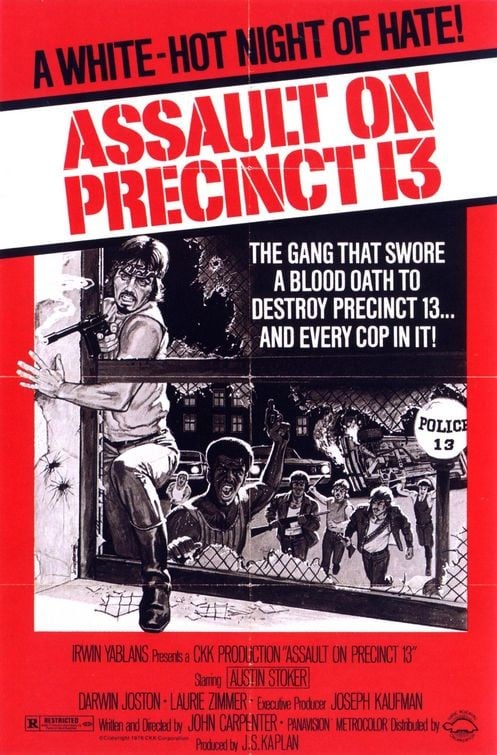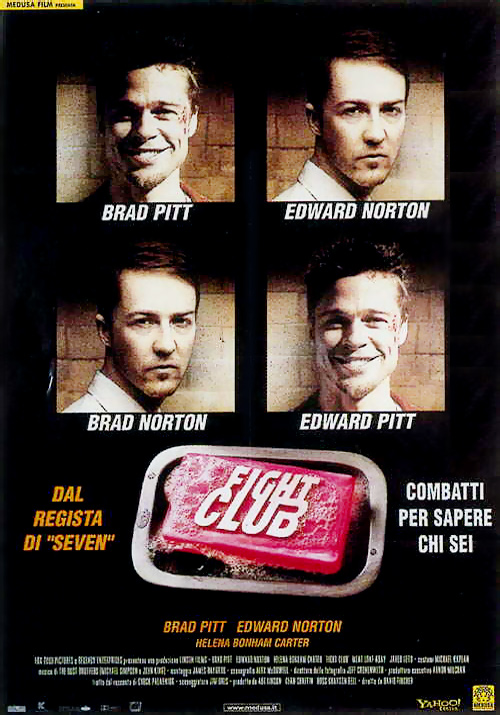Dolls di Takeshi Kitano - Genere: drammatico - Giappone, 2002
Negli ultimi due mesi circa, per ragioni strettamente legate all'università, mi sono trovato ad approfondire la filmografia di Takeshi Kitano, del quale avevo visto molto poco e che non ero riuscito a digerire completamente, a fronte di un indiscusso talento registico e di messa in scena. Violent Cop, ad esempio, si era fatto apprezzare per l'idea di fondo e per il crudo sarcasmo di alcune sue scelte, ma manifestava uno stile ancora troppo impreciso per dare l'idea del grande autore che Kitano senza dubbio è. Dolls, film in concorso a Venezia 2002, ha spazzato via tutti i miei dubbi residui derivanti dalla visione dei titoli che già conoscevo e mi ha confermato, con la forza del suo stile e delle sue scelte, la grandezza del cineasta giapponese.
Entro la cornice di un tradizionale spettacolo di Bunraku (una sorta di equivalente delle marionette occidentali), Kitano incrocia tre vicende diverse, accomunate dalla loro profonda drammaticità. Si tratta di tree linee narrative che, per quanto del tutto indipendenti, si troveranno a intrecciarsi spesso l'una con l'altra in una maniera assolutamente splendida (e splendidamente resa dalla regia sempre elegante di Kitano). Attorno al vacuo peregrinare di due giovani amanti legati da una corda rossa (immagine quasi senza tempo per la icasticità e la sua forza visiva, che diventa ancora più pregnante se si considerano le motivazioni di questo accadere), si collegano il languido ritorno di un capo yakuza (soggetto prediletto di Kitano) su una panchina dove la donna che amava lo ha atteso per tutta la vita e la patetica vicenda del rapporto fra una pop star e un suo grande fan. Utilizzando un montaggio che oscilla continuamente sui piani temporali e ricompone poi le sequenze narrative in un quadro sempre credibile ed estremamente agile, Kitano confeziona un prodotto di grande pregio che riesce a toccare senza essere stucchevole.
Abitato da un pessimismo estremo sull'esito delle vicende raccontate, meraviglioso per la sua bellezza autoreferenziale (che forse si traduce in un leggero vento d'accademismo? E' possibile, ma i pregi sono senza dubbio superiori nel bilancio complessivo), Dolls è un film che non può non rimanere impresso per la forza delle sue immagini e l'evocatività della sua scrittura.
VOTO: 8/10