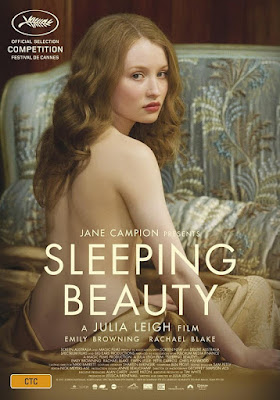Qualcuno da amare di Abbas Kiarostami - Genere: drammatico - Iran, Francia, Giappone 2012
Che Kiarostami sia per molti versi uno dei registi contemporanei più interessanti è un dato di fatto; anche i grandi però sbagliano o meglio, ogni tanto, si concedono dei passi falsi. Qualcuno da amare è l'errore di Kiarostami, un cambiamento di rotta a mio avviso piuttosto infelice in una carriera di tutto rispetto. E' bene intendersi subito e specificare che questo film, in cui il regista sceglie di esplorare il Giappone, non è pessimo né mal realizzato, ma non sembra davvero essere un film di Kiarostami.
Al di là dell'ambientazione assolutamente inedita, l'unico tratto tipico del regista che questo film conserva è il tema della falsità, che qui si esprime nella falsa relazione "nonno-nipote" che si instaura fra i due protagonisti, una giovane prostituta e un professore universitario in pensione. Il problema è che questa falsità, questa doppiezza, si situa - contrariamente a quanto avviene in titoli come Il sapore della ciliegia - soltanto a livello diegetico, mancando del tutto l'elaborata analisi sul linguaggio cinematografico che contraddistingue normalmente i film di Kiarostami.
Qualcuno da amare è un film dalle grandi pretese, che sembra voler indagare l'universo puntiforme delle relazioni umane, ma lo fa scegliendo un contesto (il Giappone) che risulta drammaticamente a-specifico: il film avrebbe potuto benissimo essere ambientato in qualsiasi parte del globo; perciò perché non tornare nei luoghi già ampiamente esplorati nella filmografia precedente e scegliere di spingersi all'estremo Est, donando al film una patina di inverosimiglianza che fa sembrare il film una copia malscritta di un Kim Ki-Duk depauperato delle sue peculiarità stilistiche?
E' un interrogativo senza risposta, così come senza risposta rimangono molti altri elementi, appositamente sospesi in un film che si caratterizza più per le sue assenze che per altro. I dialoghi (non so dire se questo sia un problema di doppiaggio o sceneggiatura) sono spesso piuttosto banali; ciò che si salva è in generale la fotografia, niente più che discreta, e una buona anche se non molto originale idea di fondo. A ciò aggiungiamo alcuni (rarissimi) momenti in cui il regista sembra aver ritrovato la strada di casa e si concede qualche attimo di indagine estetica più approfondita.
In generale il film è caratterizzato da un ritmo lentissimo, ai limiti dell'immobilità. In questo silenzio degli spazi e dei tempi tutto è estremamente dilatato e c'è spazio per la caratteristica migliore della pellicola, quello che a proposito di Xavier Dolan ho definito fenomenologia delle passioni umane. In questo caso tutto acquista un aspetto relazionale e il film diventa la storia di un diacronico dispiegarsi di amori e disamori da cui emerge in generale un paralizzante senso di solitudine. Un peccato che Kiarostami non abbia voluto osare di più, perché il risultato sarebbe potuto essere decisamente migliore.
VOTO: 6/10
VOTO: 6/10